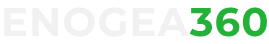Paesaggio, Geologia, Microclima
Nella pagina Leggere il Paesaggio ho già spiegato quanto sia importante padroneggiare quest’arte poco conosciuta, e per la verità semplicissima da apprendere.
Adesso è il momento di passare dalla teoria alla pratica e di spiegare attraverso alcuni esempi come il paesaggio possa raccontarci tante cose che spesso sui libri risultano di non facile comprensione (e se la cosa vi incuriosisce date uno sguardo anche al capitolo Territorio nella sezione dedicata al Barolo).
Per farlo, partiamo ancora una volta dalle due immagini panoramiche utilizzate nelle pagine precedenti e, invece di soffermarci sul contesto, proviamo ad analizzare il profilo delle colline. Nella prima immagine, che copre gran parte del comune di Barbaresco e le MGA di Neive in prossimità del fiume Tanaro, esso risulta particolarmente dolce e arrotondato, come è tipico delle Marne di Sant’Agata Fossili e dei suoli con una maggiore presenza di limo e argilla.
Nella seconda appare invece subito evidente come i fianchi delle colline siano più ripidi e in alcuni casi anche profondamente erosi, in particolare se si ruota l’immagine di 180 gradi in direzione di Cappelletto e dell’estremo meridionale e più elevato della denominazione. Di nuovo, la spiegazione si lega alla geologia, e in particolare alla Formazione di Lequio, che in virtù della maggiore presenza di sabbia al suo interno risulta appunto più erodibile rispetto alle Marne di Sant’Agata Fossili.
La terza immagine ci parla invece dei suoli. Come ricorderete, nella pagina Un po’ di geologia abbiamo introdotto la fondamentale distinzione tra suoli giovani e suoli evoluti. I primi, tipici dei versanti più ripidi, sono di colore chiaro, mentre i secondi, tipici dei versanti più dolci, sono in genere di colore rossastro. E ciò che vedete sullo schermo ne è la dimostrazione più evidente.
Sempre la terza immagine, ruotata ancora una volta di 180 gradi in direzione di Cappelletto, ci racconta anche del microclima più fresco che caratterizza la parte meridionale della denominazione, testimoniato dalla maggiore presenza di boschi. Ad influenzare il microclima è senza dubbio la quota altimetrica più elevata, ma anche e soprattutto la conformazione delle colline e della valle lungo la quale corre il confine della denominazione (in rosso nelle immagini). Una valle lunga e stretta, visibile in modo ancora più chiaro nella quarta immagine, che scende da sud verso nord incanalando i venti freschi provenienti dall’Alta Langa.
In termini più generali, la zona del Barbaresco, se paragonata a quella del Barolo, risulta in media meno piovosa e leggermente precoce in tutte le fasi fenologiche della vite, vendemmia compresa.
Altra particolarità che sicuramente avrete già notato sono i profondi calanchi che segnano il paesaggio di questa parte della denominazione, di cui il più profondo e spettacolare è conosciuto come Rocche dei Sette Fratelli. Createsi nel corso dei millenni in seguito all’erosione dovuta alle acque superficiali, queste “rocche” ci testimoniano anche della particolare struttura della Formazione di Lequio, caratterizzata da strati di marna grigia e da altri di sabbia cementata, conosciuta localmente anche come Pietra di Langa (quinta immagine).
Diverse sono invece le “rocche” che si sviluppano a nord lungo la valle del Tanaro, dato che gli strati che si possono osservare nell’ultima immagine sono espressione delle Marne di Sant’Agata Fossili laminate. Diversa è anche l’origine: a differenza delle Rocche dei Sette Fratelli, essa è dovuta principalmente all’azione erosiva del fiume Tanaro.
Nota per i lettori non di lingua italiana: la parola “rocche” è di uso strettamente locale e non è traducibile in inglese, se non con le parole cliff e ravine che ne farebbero tuttavia perdere il lato più romantico e ancestrale.